Burkini, il dibattito sul velo visto da una spiaggia della Tunisia


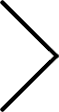
La novità non è la veste “islamica” ma l’idea di proibirla. Osservando una affollata spiaggia di domenica in un vicino paese arabo, ad Hammamet (Tunisia), credo di aver capito che il “burkini” doc (che poi è un marchio registrato) non sia presente, ci sono varie modalità analoghe di stare in spiaggia con velo o cappellino e con veste che sfocia in gonna-tunica o in pantaloni stile tuta (ci sono anche donne locali in bikini o monokini, direi un terzo del totale).
La soluzione pantaloni stile tuta sembra più comoda rispetto a gonna o tunica. La cosa più importante è che le donne sono presentissime e allegre in spiaggia, portano con sé bimbi e ragazzini e stanno mescolate con gli uomini. Avevo scritto sul mio profilo Facebook che mi sembra un dibattito fittizio, una distrazione di massa. Ci ho pensato meglio. La questione della oppressione delle donne nei paesi arabi o comunque islamici ovviamente è un problema importante (come lo sono l’omofobia e in generale la negazione dei diritti e delle libertà individuali).
Ma come si vestono, il capo coperto, etc. non è certo un problema fondamentale, fino a quando non viene imposto con la legge o la violenza. In un mondo afflitto da guerre assurde, violenze, miseria, malnutrizione, crisi climatiche e ambientali e così via porsi il problema di quanto siano effettivamente libere le donne musulmane nel decidere come vestirsi in spiaggia è bizzarro, specioso, direi quasi un po’ perverso. Infatti il dibattito è accanito tra noi, europei bianchi e soprattutto laici, mica tra loro o con loro.
La novità non è l'(eventuale) aumento della copertura della testa o delle gambe da parte delle donne musulmane. La novità è l’emergere di pezzi di opinione pubblica, di ceto politico, di femminismo europei che prendono posizione a favore del divieto di indossare certi abiti. Sì, del divieto, di questo si parla, anche se con un tale pressapochismo giuridico e amministrativo da far pensare che neanche i più proibizionisti ci credano davvero. Chi e come stabilisce la congruità dell’abito con le prescrizioni laiche? Quale la differenza tra l’abito scelto e l’abito imposto? E le sanzioni sono penali o amministrative?
Questa, che a me pare una scivolata proibizionista illiberale velleitaria è la novità, l’oggetto del contendere, il motivo per cui il dibattito è vivace accanito e purtroppo inevitabilmente attraente. Nella novità proibizionista confluiscono due filoni diversi ma entrambi inquietanti. Da una parte una nuova variante un po’ autoritaria del femminismo che vuole proibire (non solo contrastare culturalmente ma proprio proibire con la forza della legge) tutti i comportamenti che non corrispondono a una certa idea precisa della dignità femminile e quindi la prostituzione, la gestazione per altri, ora il burkini e domani probabilmente lo stesso velo.
Dall’altra l’islamofobia. Ovvero l’opposizione – inevitabile e giusta – all’islamofascismo, all’integralismo islamico che pretende di imporre le sue norme, o viene strumentalizzata o degenera in una sorta di islamofobia, in un clima da crociata, da jihad al contrario. La discussione sul carattere intrinsecamente illiberale o meno dell’Islam – e quindi sulla necessità di contrastarlo o meno in quanto religione – ha una sua dignità culturale. Ma l’idea di usare la forza dei divieti, di nuovi divieti su temi scelti come simbolici, per mettere in crisi l’Islam è grottesca e velleitaria, non può portare a nulla di buono. Ancora non si capisce se è una nuova malattia ideologica del 21esimo secolo, o semplicemente il risultato di emotività e paure troppo poco razionalizzate.


